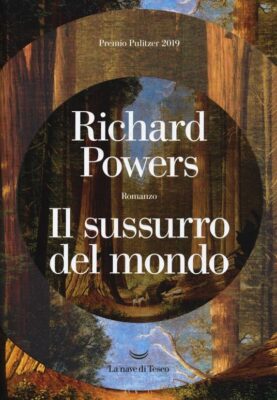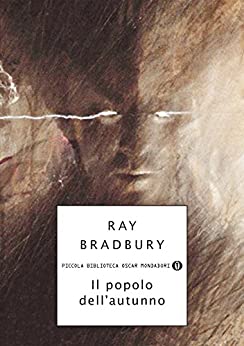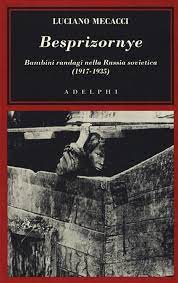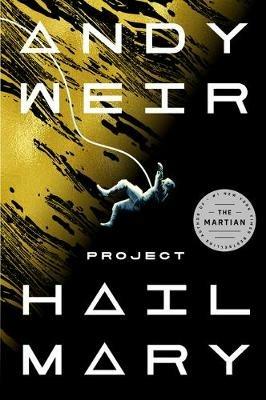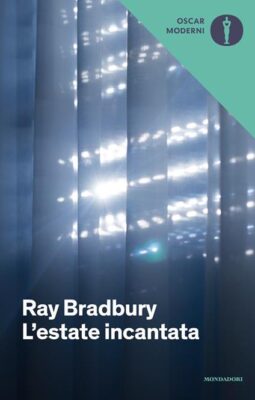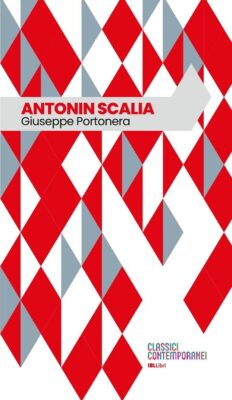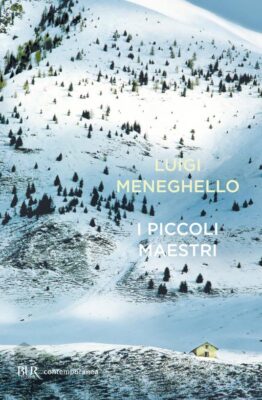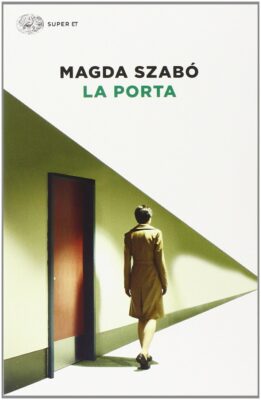
È una crepa nel presente che cresce come un vortice, attirando moti d’aria e d’attenzione, perché non si può smettere di leggere. I personaggi sono introdotti con indizi che a mo’ di esca, attraggono e seducono, evocando una irresistibile curiosità.
–
Gli eventi e i luoghi sono sorgenti di misteri che veicolano la narrazione. Anche rimanendo tali, li sentiamo scandire il ritmo delle vicende.
–
La descrizione dei personaggi si accompagna ai loro atti e alla osservazione partecipante dell’autrice che è una dei partecipanti. Si è nel dubbio se la scrittrice stia rievocando la sua biografia, o se sia una inventata. In ogni caso, le protagoniste si sdoppiano nell’offrire un diario degli eventi. I quali a loro volta viaggiano in un binario esterno cronologico e uno interiore che curva e si torce nelle storie di vita accadute di ognuno.
–
Nonostante i rimandi e le spirali, non si hanno sensazioni di pesantezza nel voler definire un ordine logiche di cause che scateneranno nuovi sommovimenti. Anzi, il lettore è invitato a supporli amplificando una ricca offerta di climax nella narrativa.
–
È una magnifica prova di scrittura per Magda Szabò, non a caso ritenuta una delle scrittrici ungheresi più autorevoli del ‘900. Dovette subire decennali e multiple forme di censure, resistendo comunque, attraverso un’incessante opera di libera divulgazione, tesa a scandagliare i processi più profondi dell’animo umano, correlati a precise e tragiche vicende storiche.
–
La storia delle protagoniste è anche uno specchio della storia del popolo ungherese, con rimandi continui tra gli anni e i secoli. L’inconscio di una bimba è quella di un popolo, e ogni ciclo famigliare costituisce una individuazione del corso di crescita dell’Ungheria.
–
4-6 “[…]. I miei sogni sono assolutamente uguali, tessuti di visioni ricorrenti. Sogno sempre la stessa cosa, sono in piedi, in fondo alle nostre scale, nell’androne, mi trovo sul lato interno del portone con il telaio d’acciaio, il vetro infrangibile rinforzato di tessuto metallico, e cerco di aprirlo. Fuori, in strada, si è fermata un’ambulanza, attraverso il vetro intravedo le silhouette iridescenti degli infermieri, hanno volti gonfi, innaturalmente grandi, contornati da un alone come la luna. La chiave gira nella serratura, ma i miei sforzi sono vani, non riesco ad aprire il portone, eppure so che devo far entrare gli infermieri altrimenti arriveranno troppo tardi dal mio malato. La serratura è bloccata, la porta non si muove, come se fosse saldata al telaio d’acciaio. Grido, invoco aiuto, ma nessuno degli inquilini che abitano sui tre piani della casa mi ascolta, non possono farlo perché – me ne rendo conto – boccheggio a vuoto come un pesce, e quando capisco che non solo non riesco ad aprire il portone ai soccorritori, ma sono anche diventata muta, il terrore del sogno raggiunge il culmine. A questo punto vengo risvegliata dalle mie stesse urla, accendo la luce, provo a dominare il senso di soffocamento che mi assale sempre dopo il sogno, intorno ci sono i mobili conosciuti della nostra stanza da letto, sopra il letto l’iconostasi di famiglia, i miei avi parricidi che indossano i dolman con gli alamari secondo la moda del barocco ungherese o del biedermeier, vedono tutto, capiscono tutto, sono gli unici testimoni delle mie notti, sanno quante volte sono corsa ad aprire la porta agli infermieri, all’ambulanza, quante volte ho provato a immaginare, mentre udivo filtrare dal portone aperto il passo felpato di un gatto, o lo stormire delle fronde, invece dei noti rumori diurni delle strade ora ammutolite, che cosa succederebbe se un giorno lottassi invano e la chiave non girasse nella serratura. I ritratti sanno tutto, in special modo ciò che mi sforzo di dimenticare, che ormai non è più sogno […]”
–
Una governante e la padrona in perenne conflitto che ricercano comunque attraverso gli anni un universo coerente circa gli eventi subiti e immaginati, perché questi non cadono mai nel participio passato. Rimangono lì, modificando lo spazio, indirizzando i comportamenti, coltivando le superfici perennemente seminate di nuovi simboli.
–
L’ossessiva descrizione degli ambienti e delle persone fin nei minimi particolari, potrebbe instillare un pigro e sonnolento giudizio circa la dilatazione temporale delle storie. Quasi uno stato di indugio autocompiaciuto. In realtà ogni offerta degli scenari provoca uno slittamento semantico che ricompone un nuovo quadro di significato. S’aprono ulteriori direzioni che avvertono nuovi accadimenti in relazione con quelli accaduti.
–
La doppia riflessione su una narrazione che è già una strada di analisi, trasla ciò che è compiuto accostandolo a ciò che in quel momento è considerato l’attimo presente. Il passato si espande nel presente, ma non dilegua, perché lascia aperta una porta al lettore, illudendolo che sia il censore che finalmente risolve il dissidio, ma che in realtà diviene il vettore di una nuova strada possibile: cioè il futuro.
–
Gli oggetti, i luoghi apparentemente banali e i dialoghi di raccordo, d’improvviso evocano le guerre mondiali, quelle dell’ottocento, le dominazioni subite e inflitte ai confinanti. Le prime forme statuali emergono d’improvviso, come mattoni nello spazio in cui i protagonisti si muovono. Ogni famiglia è una comunità, e questa è un popolo. La città è la nazione ungherese e questa è parte dei popoli che in essa la attraversarono e che ancora lì sono presenti, tra i cimiteri, le nascite, le guerre, e le stagioni.
–
La governante è la padrona instaurano un dialogo ininterrotto, scambiandosi a volte il ruolo della coscienza che disvela, e quello dell’errante cieco, sordo e muto. Eroiche e malate entrambe. Ignare comunque di portare l’eredità di questa storia personale e collettiva, anzi di esserne loro stesse un simbolo che via via si accosta a tutti gli altri di questo percorso accidentato tra le porte, le serrature, e i muri: ostacoli prima, illusioni dopo, ed enigmi sempre.
–
33-34 “[…] Al momento del mio risveglio non la vidi in casa, né in strada quando partii per l’ospedale, ma il marciapiede scopato e sgombro di neve davanti al portone rivelava la presenza del suo lavoro. «Evidentemente Emerenc sta facendo il giro delle altre case», spiegai a me stessa mentre il taxi mi portava a destinazione; non ero piú angosciata, avevo il cuore leggero, sentivo che in ospedale mi aspettavano solo buone notizie, ed effettivamente fu cosí. Rimasi fuori fino all’ora di pranzo, rincasai affamata, sicura che lei fosse là seduta nell’appartamento e aspettasse il mio ritorno, ma mi sbagliavo. Mi trovai nella situazione, cui non ci si riesce mai ad abituare, di chi torna a casa e non trova nessuno curioso di sapere che notizie porta, liete o funeste che siano – l’uomo di Neandertal probabilmente imparò a piangere quando capí per la prima volta di essere completamente solo accanto al corpo del bisonte trascinato nella caverna, di non aver nessuno con cui condividere le avventure della caccia, nessuno cui mostrare il trofeo o le ferite subite. L’appartamento mi aspettava vuoto, la cercai dappertutto, chiamai il suo nome ad alta voce, semplicemente non volevo […]”
–
133 “[…] Emerenc, se mai credeva in qualcosa, credeva nel tempo: il Tempo, nella sua personale mitologia, era un mugnaio che macinava senza sosta nel suo mulino eterno e dosava la tramoggia degli eventi a seconda del sacco che le persone gli posavano davanti. Nella fede di Emerenc nessuno restava a mani vuote, nemmeno i morti, non capiva come, ma era convinta che il mugnaio macinasse anche il loro grano e riempisse i loro sacchi, solo che alla fine erano altri a caricarsi la farina in spalla e a portarla via per cucinare il pane […]”
–
Il tempo, la scrittura, il ritmo, e la porta: il grande ostacolo che in realtà è tale in base alle domande che il singolo si pone. Una sfida stimolante per il lettore, perché in questo romanzo è direttamente chiamato in causa, assieme alla sua intera biografia itinerante.