
Cosa si potrebbe dire di Paul Auster? Il ritmo della narrazione è intimamente correlato con l’evento, tradotto nel fatto narrato. Lo stile è parte integrante del messaggio, e, nello scorrere del testo si apre come una gondola che culla il lettore navigando nelle acque della scrittura.
Sembra così naturale il modo in cui narra. Rievoca riflettendo nell’uso di stili diversi e cambiando con una eccellente appropriatezza il timbro degli aggettivi, li aggroviglia con partitivi aggettivali e predicativi in una spirale senza fine. Eppure ciò si integra in una cadenza piana, traslata in una esposizione lineare delle linee del racconto che, in modo armonico, espone lo sviluppo della trama.
–
La soffice e leggera scansione degli eventi, nasconde il pensiero a più dimensioni parallele di Paul Auster, mentre scrive. Non è dato sapere se avesse già in mente una disposizione così complessa e ben integrata. Il punto è che o se all’inizio, o durante la scrittura, o nelle successive revisioni, alla fine, emerge questo fiume lento di parole che è in realtà una individuazione di diversi piani tematici, innestati su una varietà impressionante di stili di scrittura. Il monologo apre una doppia finzione di un dialogo tra lo scrittore e i personaggi assenti. Dai tempi passati, a quelli rievocati, che giocano con l’interpretazione della loro relazione in un participio passato che allontana lo scrittore nel momento in cui rievoca.
–
I verbi e i modi sembrano orbite di un sistema solare, dove la stella pulsa una ciclica riflessione a una domanda.
–
Il libro è composto in due racconti. Si parte dell’esperienza luttuosa della morte del padre, con la quale si inizia un percorso inverso di memoria per riportarlo in vita rispetto al figlio, che già lo vedeva assente da anni. La seconda parte è dedicata a suo figlio, e qui vi sono giochi di specchi rispetto alla precedente sezione.
–
Il protagonista è lo stesso scrittore che declina in una serie di rimandi a più opere che viaggiano parallele a un tratto, incidenti in un altro, coincidenti fino ad essere completamente divergenti, mantenendo ognuna la gamma degli espedienti letterari classici di narrazione.
–
Quest’opera forse può essere anche intesa come un diario di memorie che fabbrica un romanzo per creare una vita di relazione tra il padre e il figlio, mai accaduta, e una riformulazione di domande fondamentali che rappresentano il vivere stesso dell’autore, attraverso la sua individuazione di scrittore.
–
Questo romanzo rende di più nella lettura in lingua, in particolare dell’anglo americano del nord est, che si immerge in una variazione armonica da un tono alto, elegiaco, a quello colloquiale, aneddotico e popolare. Il tono umoristico nella lingua italiana è più attenuato nei mottetti di spirito, nei giochi di parole, nei riferimenti alle ricette culinarie, ai personaggi televisivi, e più in generale alla cultura pop rievocata in lampi di frasi. Questi ultimi, però, nella cultura profonda degli USA, hanno significati che rimandano a luoghi retorici e a stereotipi sui caratteri delle persone, sui modi di dire, sulle frasi fatte, sul patrimonio di senso comune.
–
33-34 “[…] Quando ho iniziato credevo che tutto sarebbe sgorgato spontaneamente, come l’effetto di una trance. Tanta era l’urgenza di scrivere che pensavo che la storia si sarebbe fatta da sé. Ma fin qui le parole sono uscite cosí lentamente: anche nelle giornate piú produttive non sono mai riuscito a scrivere piú di una pagina o due. Come fossi malato, inchiodato da un’incapacità della mente a concentrarsi su quello che sto facendo. Piú volte ho visto i miei pensieri volare via dal lavoro che ho di fronte. Non fa in tempo a venirmi un’idea che questa ne evoca un’altra, e poi un’altra, finché i dettagli non si accumulano cosí fitti che mi sento soffocare. Mai prima d’ora avevo percepito tanto chiaramente lo spazio che divide pensiero e scrittura. Negli ultimi giorni, in realtà, ho avuto la sensazione che la storia che sto tentando di scrivere sia come incompatibile con il linguaggio, e che il suo grado di resistenza a esso dia la misura esatta di come sono vicino a dire qualcosa di importante. Poi, quando arriverà il momento di dire l’unica cosa importante (sempre ammesso che esista), non ci riuscirò. C’è stata una ferita, e scopro adesso quanto fosse profonda. Invece di guarirmi come pensavo, l’atto di scrivere l’ha tenuta aperta. Ne ho sentito anche il dolore, concentrato nella mia mano destra, al punto che ogni volta che prendevo la penna e la premevo sul foglio la sentivo straziata, dilaniata. Invece di compiere la sepoltura di mio padre queste parole l’hanno tenuto in vita, forse adesso piú che mai. Non solo lo vedo com’era, ma com’è ancora, come sarà, e tutti i giorni è qui a invadere i miei pensieri penetrandovi furtivo, senza preavviso; disteso nella bara sotto terra, col corpo ancora intatto, le unghie e i capelli che continuano a crescere. Ho l’impressione che, se voglio capire qualcosa, dovrò entrare in quell’icona di tenebra, penetrando l’oscurità assoluta della terra. […]”
–
7-12 “[…] Ancor prima di fare i bagagli e partire per le tre ore d’auto che ci separavano dal New Jersey, sapevo che avrei dovuto scrivere di lui. Non avevo un progetto, né una precisa idea di che cosa questo volesse dire. Non ricordo nemmeno di averlo stabilito. Semplicemente era lí, come una certezza, un comandamento che cominciò a imporre la sua legge nel momento in cui appresi la notizia. Pensai: mio padre non c’è piú. Se non faccio in fretta, tutta la sua vita scomparirà con lui. Riflettendoci adesso, anche da una distanza breve come tre settimane, quella reazione mi pare molto strana. Da sempre ero convinto che la morte mi avrebbe stordito, paralizzato di dolore; ma adesso che era accaduto, non versai una lacrima, non mi sentii come se il mondo attorno a me fosse crollato. Chissà come, mi scoprii preparato ad accettare la sua morte, per inaspettata che fosse. A turbarmi era un altro pensiero, staccato dalla morte di mio padre e dalla reazione che mi suscitava: il constatare che non aveva lasciato tracce. Non aveva moglie, né una famiglia che dipendesse da lui, nessuna vita sarebbe stata modificata dalla sua assenza. Forse per un attimo avrebbe spaventato un gruppetto di amici, scossi non meno dall’idea dei capricci della morte che dalla perdita subita; ma sarebbe stato solo un breve cordoglio, poi piú nulla. Come se non fosse mai vissuto. Era assente già prima di morire, e le persone piú vicine a lui avevano imparato da un pezzo ad accettarne l’assenza, considerandola il tratto piú essenziale del suo essere. Adesso che se n’era andato, non sarebbe stato difficile per il mondo assimilarne la scomparsa definitiva: la natura della sua vita – una specie di morte anticipata – aveva preparato il mondo circostante alla sua morte, e se e quando lo avessero ricordato, sarebbe stato una memoria vaga, niente piú che vaga. Digiuno di passioni per le cose, le persone o le idee, incapace o avverso a svelarsi in qualsiasi circostanza, era riuscito a mantenersi staccato dalla vita evitando di tuffarsi nel vivo delle cose. Mangiava, andava al lavoro, aveva amici, giocava a tennis, eppure non era presente. Era un uomo invisibile nel senso piú profondo e piú concreto: invisibile agli altri, e molto probabilmente anche a se stesso. Se da vivo continuavo a sondarlo cercando in lui il padre che non c’era, sento ancora il bisogno di cercarlo da morto. La sua morte non ha cambiato nulla. L’unica differenza è che mi manca il tempo. È vissuto da solo quindici anni. Caparbio, opaco, come immune dal mondo. Piú che un uomo che occupa uno spazio, sembrava un blocco di spazio impenetrabile in forma di uomo. Il mondo lo colpiva di rimbalzo, gli sbatteva contro, a volte aderiva a lui, ma non lo attraversava mai […]”
–
53-55 “[…] Per tutta la vita sogno di diventare milionario, di essere l’uomo piú ricco del mondo. Non desiderava tanto il denaro in sé, ma ciò che esso rappresentava: non solo il successo agli occhi del mondo, ma uno strumento per rendersi intoccabile. Possedere denaro non significa soltanto la possibilità di comprare le cose, ma anche la certezza che il bisogno universale non ti toccherà mai. Denaro come protezione, dunque, non come voluttà. La povertà sofferta da bambino, e la conseguente vulnerabilità ai capricci del mondo, gli resero la ricchezza sinonimo di immunità dal male, dalle sofferenze, dall’essere vittima. Non cercava tanto di comprarsi la felicità quanto l’assenza di infelicità, e i soldi divennero la panacea, l’oggettivazione dei suoi desideri piú profondi e inesprimibili. Non ambiva a spenderli, ma a possederli, alla certezza di poter contare su di loro. Insomma, il denaro non era un elisir, ma un antidoto: la bottiglietta che ti porti in tasca avventurandoti nella giungla… nel caso ti mordesse un serpente velenoso […]”
–
Dal secondo racconto lui, lo scrittore che è padre anch’esso appena separato dalla moglie, cerca però un contatto con suo figlio e lo richiama nella sua biografia adolescenziale.Rimane affascinato dalla scoperta che Anne Frank è nata lo stesso giorno di suo figlio. Il dodici giugno. Sotto il segno dei Gemelli. Un’immagine gemellare: un mondo dove tutto è duplice, e ogni cosa si ripete sempre due volte. La memoria: lo spazio in cui le cose accadono per la seconda volta.
–
E da qui si esplicita la solitudine come spinta a utilizzare il potere della memoria e il suo ruolo nel plasmare la nostra identità.
–
Il secondo racconto è suddiviso in paragrafi numerati ove ogni volta si ricomincia a porre lo schema del richiamo del ricordo. Talvolta è autobiografico, altrove è inventato, ed entrambi gli inizi sono riproposti in modo ciclico con persone e tempi diversi. La memoria è lo sfondo di un oceano che, in base alle nostre attuali presenze, lascia riaffiorare frammenti temporali.
–
L’uso di analogie e assonanze tra nomi di figli, luoghi e personaggi serve a creare un’atmosfera onirica e a sottolineare la fluidità della memoria. I confini tra la realtà e l’immaginazione si sfumano, e il lettore è invitato a immergersi nel flusso di coscienza del narratore.
L’archeologia della memoria ha anche la funzione di connettersi con le persone amate e con quelle fissate in rapporti interrotti.
–
Vi è un paragrafo in cui Auster sempre nel secondo racconto, analizza dal francese “x, persona, me stesso, vuole dire”. Questa locuzione composta non è banale. Egli scrive che sotto sotto “intende dire”. Cioè questa è la sua intenzione di dire, dove questo dire ancora deve uscire fuori, ovvero entrare nel linguaggio che si manifesta nel dire orale, nella scrittura, nella rilettura. Questo “dire” non è una semplice asserzione, un sasso gettato lì, intero, intonso, immutato. È una selezione di altri detti, di memorie, di situazioni, di tutti i se stessi del passato, dimenticati e di poco ora riaffiorati. Sono tracce indirette che hanno costruito le prime esperienze del bimbo con il padre. Le esperienze primigenie sono a noi oscure, perché sono servite a creare le strutture del ricordo. Ciò implica che noi siamo individuazioni limitati nel “dire”.
–
Non è un caso che alla fine del racconto si propone la lettera di Nadežda Jakovlevna Mandel’štam che scrive al suo amato Osip Ėmil’evič Mandel’štam imprigionato nel gulag sovietico, non sapendo se sia vivo o no. Da un ricordo rievocato Ella immagina che Osip stia pensando a Lei e che stiano insieme in questa memoria del futuro inventata. La meraviglia fu che Osip scrisse veramente una lettera analoga dal gulag prima di morire.
–
Il linguaggio è uno strumento potente, ma non è in grado di esprimere tutto. Ci sono cose che non possiamo dire perché non le conosciamo o perché non abbiamo le parole per farlo. Il “dire” che non può essere detto rimane nell’ombra, come una parte di noi stessi che non può essere completamente espressa. La consapevolezza della nostra finitezza ci spinge a vivere con maggiore intensità, rendendo giustizia al tempo che abbiamo a disposizione. La lettera su indicata è un esempio di come la memoria possa creare un ponte tra il passato, il presente e il futuro.
–
La “solitudine” è posta come una condizione necessariamente legata alla creazione artistica, e in particolar modo all’atto della scrittura, che non è intesa univocamente nell’isolamento, ma in una meditazione che tenta di ricongiungere ciò che è separato, all’interno di una nuova prospettiva che tenta di allargare la vita, un attimo prima della fine, attraverso la produzione e la fruizione artistica. Il centro della narrazione, infatti, non è un evento accaduto e raccontato, ma l’atto stesso del racconto e della parola. In questa oscillazione vi è uno spostamento continuo della voce narrativa, che si tramuta in quella del racconto stesso che visita i personaggi.
–
Qui si mostra anche il paradosso insito nella condizione della solitudine dello scrittore che, sebbene sia fisicamente solo in una stanza, è accompagnato dai fantasmi della letteratura e della scrittura degli altri. La “solitudine si mette a parlare”, ed è attraversata da citazioni esplicitate o semplicemente incorporate nel testo, che rimandano alla tradizione della letteratura e della cultura universale, da Pinocchio alle Mille e una notte, dalle riflessioni sulla mnemotecnica ai Pensieri di Pascal, dalle poesie di Holderlin fino alle riflessioni di Freud sul perturbante.
–
La scrittura si ripiega e parla di se stessa, del suo infinito cominciare a dire l’evento che non può più tornare ad essere, ma è continuamente. Non resta che dire questa impossibilità, e l’unico modo in cui ciò è possibile, è quello della scomparsa di un io narrante che si fonde con la pluralità e l’instabilità di una voce neutra, quella della voce narrativa. Così, tra la scomparsa e la solitudine si viene a creare una risonanza fondamentale che riguarda il modo di creazione dell’opera. La scomparsa non è causa della solitudine e la solitudine non è uno stato di abbandono.
–
E di ciò il lettore ne è testimone.
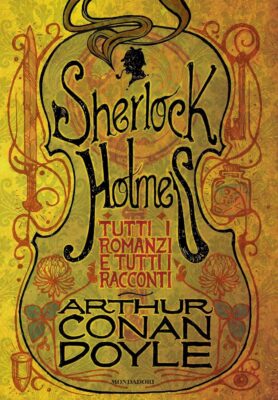

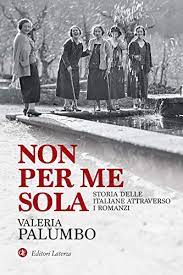

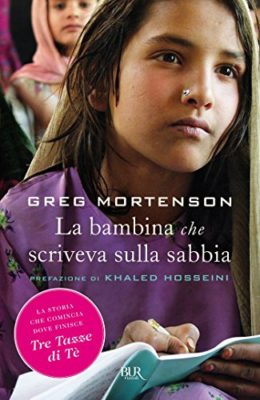
 –
–