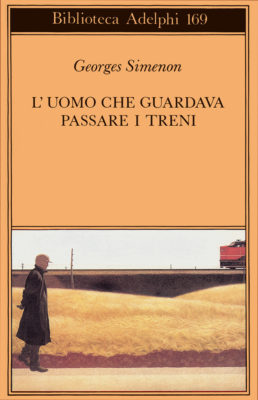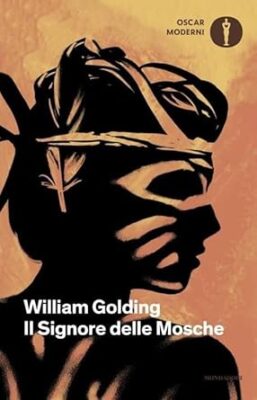
Filippo Donini (Traduttore), Mondadori, Milano, 2024
– (Ed. Originale: Lord of the Flies, 1954)
Il signore delle mosche è l’altra faccia del battito del nostro cuore, ovvero la risonanza che non è voluta sentire. Ciò che è di più intimo di noi nella veste dell’animo, o della psiche o del carattere, considerato come il tesoro del fiore più intimo, ha anche il petalo più orrendo e crudele, secondo William Golding.
–
In base alle esperienze che visse durante la seconda guerra mondiale e alla sua professione di docente, in particolare rivolta ai bimbi, ebbe quotidiani elementi di riflessione partecipata circa le inclinazioni e i modi spontanei di aggregazione e di determinazione dei ruoli, tra i gruppi informali e le comunità, come quelle scolastiche o più semplicemente tra un gruppo di amici.
–
Il romanzo ha per matrice originaria quella di una lezione didascalica di fatti narrati in modo incrementale che offrono una conoscenza progressiva del tema posto. Non è un caso infatti che, nonostante le opere successive, i ruoli di docente universitario, di scrittore e di intellettuale, fu sempre considerato un insegnante. Più volte citò gli aneddoti di come i lettori, scrivendo lettere di plauso e di chiarimento, lo considerassero il maestro che rispiega la lezione per far comprendere appieno elementi non del tutto chiari.
–
Certamente l’opera non è solo una esposizione, perché, se così fosse, risulterebbe alquanto piatta e noiosa in conformità alle aspettative rivolte alla fruizione estetica della lettura di un romanzo. Vi sono gli elementi salienti che pongono tensioni estreme, oscillando tra la sopravvivenza, il gesto eroico e generoso, in contrappunto alla sopraffazione, alle lotte per il potere, alla razzia, e alla violenza più cruda.
–
La descrizione quasi anatomica dei caratteri fisici e morali è sapientemente connessa al ritmo della narrazione e alla dinamica avvincente degli eventi. Vi è una scrittura giornalistica che muta in una scansione telegrafica degli elementi di conflitto, affinché il lettore senta dentro di sé la tensione della fatica, e il peso del dolore.
–
Nei momenti di relativa calma, l’apparente stasi, invece, è avvolta dall’angoscia più cupa che si trasforma nel timore, quando i pericoli evocati, compaiono nella loro intera crudezza.
–
Ebbe un enorme successo questa prima opera, sia per lo stile amichevole e confidenziale per il lettore degli anni cinquanta che si formava nei pocket tascabili sia per la complessità delle stratificazioni di pathos crescenti, determinando una tensione da evento sportivo.
–
I soggetti sono i bambini, che, dispersi su un’isola cercano di sopravvivere, tentando nel contempo di farsi avvistare da qualche aereo o nave. Dopo l’inizio quasi idilliaco di un paradiso che sembra tutto offrire in un clima confortevole, la consapevolezza della limitazione delle risorse e delle preoccupazioni per il futuro, facilita l’emersione di loro inclinazioni tese a compiere atti sempre più tragici e crudeli.
William Golding ha una visione pessimistica dell’animo umano. Volutamente e con metodo non ha voluto porre un piano di una differenza di religioni, o di visioni ideologico-politiche, o di individui fuori della norma, devianti massimi per una sorta di malattia mentale, o di perversione morale.
–
Non ha voluto neanche porre l’aggregato, la comunità, la società come enti metafisici che determinano primariamente le gesta e i conflitti tra gli umani. No, perché le considera un derivato delle interazioni sociali che avvengono in primo luogo tra gli individui. Non vi sono adulti, per analizzare quasi da etologo, come gli stessi bimbi in determinate circostanze ambientali, e quindi non storiche, crescendo, diventano adulti nel macchiarsi del crimine. La colpa non è solo scaturita dal singolo atto, ma anche dalla consapevolezza di aver dentro il proprio cuore l’inclinazione all’orrore e alla crudeltà. Anzi, l’adulto è tale, perché rivela a sé stesso che l’incanto dell’innocenza degli imberbi è una bugia.
–
L’autore, però, nel porre i suoi argomenti, rivela alcune criticità di questa visione innata, che diventa a sua volta quasi presupposta, e non ben determinata. È consigliata la lettura della post-fazione, scritta anni dopo, contraddistinta da riflessioni più ponderate e meno apodittiche.
–
Fanno paura questi bimbi, in particolare nell’elemento più cupo e sotterraneo nel dubbio che siano specchi dei pensieri che abbiamo avuto nell’infanzia e che determinarono alcuni tratti di ciò che siamo ora.
Un libro da leggere tutto di un fiato, senza conoscere in dettaglio la trama, perché è una doccia fredda che si spera sia salutare.