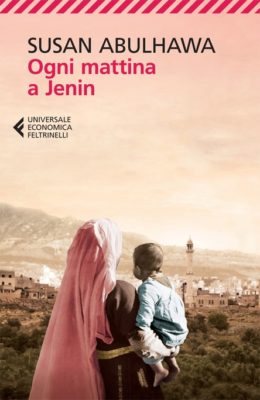
tra genitori e figli
“ Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano Seconda edizione digitale 2016. Traduzione dall’inglese di Silvia Rota Sperti
L’oscillazione tra Passato e Presente, tra radici e foglie,
tra genitori e figli.
Un libro coinvolgente. Si entra in una saga epica quasi, su eventi reali. È un romanzo con personaggi di fantasia, ma che raccoglie con una precisione storica e una caratterizzazione da resoconto giornalistico, eventi che durano decenni e che trapassano intere coorti generazionali lì in Palestina. La narrazione che va avanti e indietro nel tempo. La voce narrante descrive come i due ragazzi inizino a parlare con lingue diverse: l’arabo Hassan impara un poco di inglese e di ebraico e di tedesco per Ari, che a sua volta apprende l’arabo. Storpio Ari, malaticcio Hassan, in disparte e presi in giro, si rifugiarono nelle letture e nelle culture dei due popoli e delle culture tedesca e inglese. Lo stile descrive il tempo e lancia per contrasto alcuni accenni del futuro, come di Yeah il padre di Hassan che impedisce al figlio di andare a studiare a Gerusalemme perché voleva che lavorasse la terra, ma si sarebbe pentito per tutta la vita.
–
“[…] Anche se gli fu negato il privilegio degli studi superiori, Hassan ricevette le ottime lezioni private della signora Perlstein, che mandava a casa il suo giovane e assiduo studente carico di libri, letture e compiti. Le lezioni erano il frutto di un accordo segreto tra Bassima e la signora Perlstein per sollevare Hassan dallo sconforto in cui era caduto da quando Yehya aveva pronunciato l’ultima parola sulla questione della scuola. […]”
–
“[…] Un attimo, il piccolo Isma’il di sei mesi era sul suo petto, tra le sue braccia materne. L’attimo dopo, Isma’il non c’era più. Un attimo può schiacciare un cervello e cambiare il corso della vita, il corso della storia. Fu un’infinitesimale scheggia di tempo a cui Dalia avrebbe ripensato più e più volte nel corso degli anni, cercando un indizio, una traccia di cosa poteva essere successo a suo figlio. Anche quando finì per smarrirsi in una realtà offuscata, continuò a cercare con il pensiero Isma’il tra quella folla in fuga. […]”.
–
“[…] Yehya calcolò quaranta generazioni di vite, ora spezzate. Quaranta generazioni di nascite e funerali, di matrimoni e danze, di preghiere e ginocchia sbucciate. […]”
–
“[…] Nel dolore di una storia sepolta viva, in Palestina l’anno 1948 andò in esilio dal calendario, smise di tenere il conto di giorni, mesi e anni per diventare solo foschia infinita di un preciso momento storico. I dodici mesi di quell’anno si riorganizzarono e turbinarono senza meta nel cuore della Palestina. […]”.
–
Moshe ruba il bimbo Isma’il per Jolanta sua moglie resa sterile dai nazisti. Ma occorre ricordare che aveva la cicatrice il bimbo, causata da suo fratellino Youssef, cadendo nel chiodo di quella culla, che la nonna considerava portafortuna. E forse quella cicatrice era un pegno di salvezza futura. Ecco anche qui il tempo va avanti e indietro, in un andirivieni come indicato nella genealogia del libro.
–
“[…] Mentre gli abitanti di ‘Ain Hod venivano costretti ad allontanarsi, privati di ogni cosa, Moshe e i compagni controllavano e saccheggiavano il villaggio appena rimasto vuoto. Mentre Dalia giaceva straziata dal dolore, delirante per la perdita di Isma’il, Jolanta cullava David. Mentre Hassan si preoccupava per la sopravvivenza della propria famiglia, Moshe cantava e gozzovigliava insieme ai compagni in una baldoria ebbra. E mentre Yehya e gli altri si allontanavano con passo angosciato dalla loro terra, gli usurpatori cantavano l’Hativka e gridavano: “Lunga vita a Israele!”. […]”.
–
Avanti e indietro nel tempo, anche qui, nell’oscillazione di un popolo che va, in una terra vista da uno e dall’altro che continuamente sfugge. Oscilla il senso temporale e il senso spaziale. Villaggi, generazioni, radici e figli, padri e foglie. Quaranta generazioni sdradicate da Almod.
Sembra un ciclo, come il numero 40 delle generazioni sdradicate. Rievoca un ciclo che si ripete come cent’anni di solitudine.
–
Nel libro vi sono le frasi in corsivo che benedicono la terra, i figli, e quelle declamate dai protagonisti quando parlano del passare delle stagioni, delle piogge che umidificano il terreno. Le parole in corsivo detengono la memoria orale della comunità: i detti, i saperi sul ciclo delle stagioni, sul raccolto, sulla nascita e sulla crescita degli olivi, dei fichi, dei figli.
–
“[…]La morte di Yeyha spinse tutti nel campo a rimboccarsi le maniche. Un febbrile senso di orgoglio avvolse Jenin e ci si diede da fare per istituire delle scuole, specialmente femminili. Nel giro di un anno la comunità di profughi costruì un’altra moschea e tre scuole, e in tutto questo Hassan ebbe un ruolo centrale ma discreto, tenendosi ai margini della quotidianità ma continuando a scrivere laboriosamente lettere e documenti. […]”
–
“[…] Papà disse: “Possono portarti via la terra e tutto quello che c’è sopra, ma non potranno mai portarti via quello che sai o le cose che hai studiato”. Avevo sei anni e i bei voti a scuola diventarono la moneta di scambio per conquistarmi l’approvazione di papà, che desideravo come non mai. Diventai l’alunna più brava di tutta Jenin e imparai a memoria le poesie che mio padre amava così tanto. Anche quando il mio corpo diventò troppo grande per il suo grembo, il sole ci trovava sempre abbracciati e con un libro tra le mani. […]”.
–
Ogni evento diventa l’occasione del ricordo, per ritornare a pensare. Il ricordo è il mantenimento della terra.
–
“[…] “Nasciamo tutti possedendo già i tesori più grandi che avremo nella vita. Uno di questi è la tua mente, un altro è il tuo cuore. E gli strumenti indispensabili di queste ricchezze sono il tempo e la salute. Il modo in cui userai i doni di Dio per aiutare te stesso e l’umanità sarà il modo in cui Gli renderai onore. Io ho cercato di usare la mente e il cuore per tenere il nostro popolo legato alla propria storia, perché non diventassimo creature senza memoria che vivono arbitrariamente in balia dell’ingiustizia.” […]”
–
Anche Amal (in italiano: speranza) rimane di ghiaccio nei rapporti con la figlia quando la partorisce. È costretta a vivere in un ciclo continuo al fine di preservare se stessa per far vivere la figlia, come se l’amore fosse la loro condanna a morte, come per il marito che per amore della terra morì in ospedale, come per Fatima per amore di Yussef che voleva far partorire i figli. Se non ami i tuoi figli, se li vuoi distaccare dalla tua terra (Palestina) allora essi vivranno, altrove, nella speranza di non conoscere l’origine e i genitori.
–
“[…] Così, smisi di leggere e di guardare i telegiornali e cominciai ad aver paura di toccare Sara, per non contaminarla con il mio destino. Perché non mi scaldasse il cuore e sciogliesse la rabbia, i fantasmi e la follia che mi portavo dentro.
Mi chiusi in me stessa. Le mie difese allontanavano chiunque osasse avvicinarsi, compresa Sara, anche se continuavo a consumare il suo profumo di notte, mentre dormiva, riempiendomi i polmoni del buonsenso che avevo bisogno di respirare. La amavo mio malgrado. La amavo immensamente. Infinitamente. E avevo paura di quell’amore così come avevo paura della mia rabbia contro il mondo. […]”.
–
Come la madre Dalia andava di notte ad accarezzare i figli.
–
“[…] La comunicazione fu interrotta. Mio fratello era irrimediabilmente perduto. Aveva attraversato l’abisso di fiamme davanti al quale io ancora esitavo, ed era atterrato sulla sponda placida e distaccata della vendetta. Aveva lasciato la sua anima a vagare per Sabra e Shatila, dove sua moglie e sua figlia giacevano in una fossa comune sotto a un mucchio di rifiuti, sotto l’impunità dei loro assassini, le promesse infrante delle superpotenze e l’indifferenza del mondo verso il sangue versato dagli arabi.
[…]”
–
E il libro continua e consiglio la lettura, perché nonostante si tenti di bloccare l’amore, il legame materno e quello tra fratelli e sorelle, il tempo alla fine tutto scoperchia, in un crescendo emotivo di una intensità unica.
