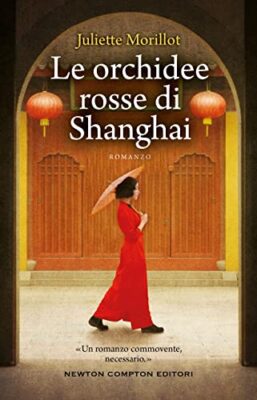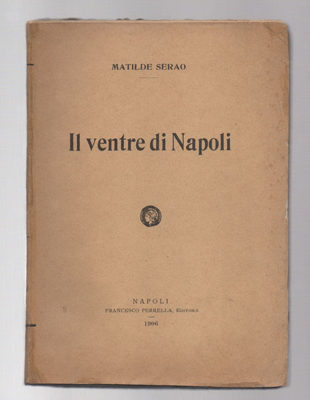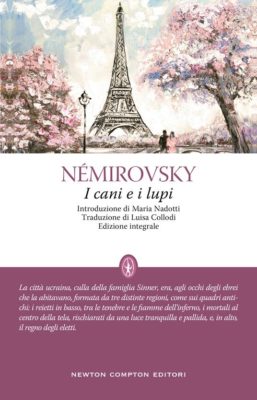di Francesca Cavallero, 2022,
Mondadori, Milano
Perdonatemi tutti, se almeno per questo consiglio di lettura entra la mia personale senile vanità, perché ho ritrovato molto dello spirito e dei modi con i quali io scrissi il mio romanzo “Dentro l’Apocalisse”. Con questo non voglio assolutamente paragonarmi o accodarmi allo stile e alla caratura del romanzo di Francesca Cavallero, ma, a differenza di molti romanzi contemporanei, qui mi sono scaturite assonanze profonde: lo stile che talvolta straborda nelle espressioni poetiche. Vi sono aggettivazioni, predicati oggettivanti, allitterazioni, sinestesie che si innestano in modo fluido nella prosa.
–
Lo stile è composito e varia in diversi ritmi e climax che si incrociano. La trama è a più livelli e coinvolge la biologia, la terra, il corpo, la relazione sociale, e l’inconscio in modo integrato e non separato, cui la sintesi rimanda a ciò che non è totalmente esprimibile dal linguaggio. Ciò crea il mistero e quindi lo sviluppo degli avvenimenti, la cui proiezione è avvertita in modo lirico e individuale, come se, appunto, il lettore fosse invitato ad abbracciare una visione estetica complessiva nel dolore, nella speranza e nello struggimento.
–
I personaggi non sono banali. E come anche nel mio libro vi sono digressioni nelle descrizioni politiche ed economiche dello scenario offerto. Sì, Francesca Cavallero non ha scritto un romanzo usa e getta ripetibile, facile da indossare e scartare un secondo dopo la fruizione veloce per un altro manufatto quasi simile.
–
Non è una lettura facile per chi legge con altre fonti di distrazioni, o per facilitare il sonno. È una lettura che richiede la tua entrata nella scena, con tutto il tuo corpo, e il pulsare delle vene, oltre al godimento intellettuale di seguire percorsi a più dimensioni interpretative e con domande non banali circa le questioni fondamentali della nostra esistenza caduca nel proprio e ciclo di vita.
–
Vi è infatti un notevole stile lirico e poetico con una sovrabbondanza di descrizioni dei fenomeni atmosferici, delle situazioni, degli ambienti, dei manufatti con le allegorie, le metafore, le sinestesie.
Si ha un’ottima conoscenza di più registri linguistici. Vi è una cura particolare della scelta degli aggettivi, delle attribuzioni.
–
Le predicazioni poi slittano in referenti testuali che partono anche dalla impressione che fanno sui protagonisti, i quali le ricevono dando l’illusione di conservarle così integre, fornendo l’occasione al lettore di goderne appieno.
–
Una finzione che è anche propria del poeta che usa i correlati oggettivi, per lasciarli presentare direttamente al lettore.
–
Le caratteristiche qualitative dei manufatti, e quelle morali degli individui, si concretizzano in stati della realtà e indicatori di senso degli avvenimenti: sono un crocevia dei timbri che scandiscono la trama del racconto. Si vuole stimolare continuamente a creare analogie e simboli nell’interpretare gli eventi.
–
Vi è una sovrabbondanza di significati in ogni scena che è incastonata in modo certosino. Una descrizione così barocca da fornire l’illusione di porre una realtà concreta, carnale, emotiva diretta.
–
Le protagoniste, tre donne, hanno avuto madri biologiche morte, o lontane, o madri putative morte ma che sono putative e nume per indirizzare gli eventi. Occorre vedere se anche loro diventeranno madri e creeranno il futuro e la speranza, ed è qui che convergeranno in un destino comune di rinnovamento, nella crescita, nella nascita e nella morte.
–
Sya, Nebra, Nadja.
Qui le donne sono viste a tutto tondo, non vi è neanche bisogno di distinzioni di genere. Sono individui, persone: ognuna ha una soggettività integra. Le protagoniste coprono la vasta gamma delle tipologie dei comportamenti sociali, delle situazioni emotive, degli odi, degli amori, delle meschinità e delle speranze.
–
Gli innesti tecnologici ampliano le possibilità di diversificare le prestazioni. In questo le donne e gli uomini sono alla pari. Anzi non vi è bisogno di un criterio di mediazione, perché la distinzione e la relativa metrica non hanno più senso. I personaggi sono robusti, poliedrici, complessi, e compongono le mille sfaccettature del cuore umano: dalla possibilità di compiere atti di generosità commovente e nel contempo di attrezzarsi ad agire nel modo più orrendo e crudele.
–
La sopravvivenza, l’accesso alle risorse, a un luogo stabile, a difendersi dalle comunità ostili, in perenne conflitto per il vincolo delle fonti di sussistenza, costituiscono i luoghi universali in cui le comunità evolvono in gruppi sociali, alleanze, strutture statuali più complesse, concertando i diritti, le norme, e gli stili di comunicazione.
Senza declamare, ma semplicemente narrando le loro avventure, di per sé nella trama, traspare la ricchezza e la centralità della donna come il perno della sopravvivenza del genere umano e come la fonte primaria di energia, che, sì può confliggere come quella dei maschi, ma che, parallelamente, costruisce e stabilisce l’ambiente in cui possano definirsi agglomerati sociali robusti e duraturi.
–
255-256 “[…] Il calore del terreno gonfio e il freddo che striscia via dalla notte si contendono il suo corpo in un caos termico che, è certa, pagherà caro. Da tempo cammina nel grigio/verde di un mattino flaccido, senza ore né minuti, arrancando fra gli acquitrini e le prime distese di tundra rigonfie di gas caldi: rottami adunchi e cavi di veicoli aerospaziali emergono dai liquami come ossa di antichi cetacei. Su alcuni Nebra registra, senza vederle, ottuse successioni di numeri, scoloriti stemmi di una o l’altra città-Stato e acronimi che per lei non hanno alcun senso. Trascina i piedi, pesanti della melma che le colma gli scarponi, attraverso la gelatina di vegetali in macerazione, sperando che i crampi bastino a tenerla cosciente. Lentamente la vegetazione cambia, si raggruma in macchie, si abbassa e infoltisce: la temperatura del terreno aumenta man mano che Nebra si avvicina alle Rowdy Mountains […]”
323-324 […] Penso che potrebbero essere trascorsi eoni dall’incidente: il tempo non ha significato mentre lo sento sgretolarsi intorno a me. Le grida sono cessate, l’intera miniera ogni livello ogni nicchia, pozzo, cunicolo sepolti nella montagna risuona di frequenze liquide. Un battito. Una consonanza. Un cuore. Nel tempo ogni suono si acquieta, riflettendosi e assorbendosi mille e mille volte fra le pareti della miniera, animandone il corpo. Nascono e crescono lussureggianti banchi floreali di profondità, che s’impadroniscono dei macchinari abbandonati e li riempiono di bisbigli. La loro è… un’acusintesi che si spiega solo ascoltando la voce dei morti, e gronda di misteri che si schiudono per me. La terra fiorisce nell’oscurità, ogni radice è fatta di suono, sangue e respiri. Sprofondano, lentamente, fino a raggiungere le cavità interne di antichi e colossali ammonoidi fossili, sepolti in sterminate colonie di madreperla. Non mi occorre vedere, ne ascolto la forma. Do loro un nome perché vivono attraverso me. I miei sensi ne ricostruiscono lo spettro dai suoni raccolti, una sinfonia discontinua che risale lungo labirinti giganti, formati dai corpi asciutti di organismi bentonici che milioni di anni hanno animato con un canto di creazione e morte
–
Qui, nella risacca antica di un oceano preistorico che si è fatto roccia, echeggia il pianto delle Madri.
«Le Madri…» mi sfugge.
La culla del nostro dolore.
La nostra eco.
Sangue e grida.
Evoluzione.
[…]”