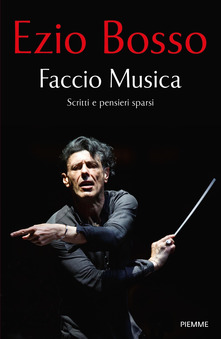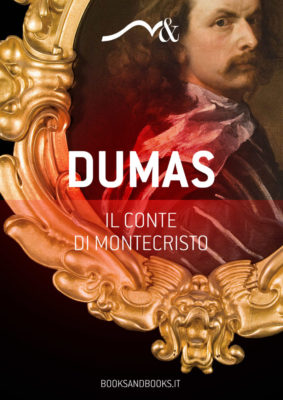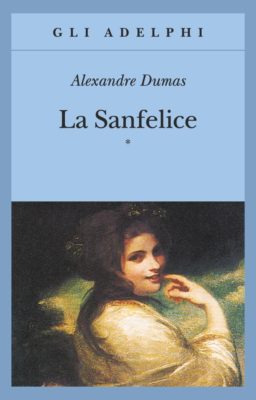
Alexandre Dumas. LA SANFELICE.
Adelphi Edizioni, Milano 1999 (gli Adelphi 144).
Titolo originale: “La San Felice”.
Traduzione di Fabrizio Ascari, Graziella Cillario e Piero Ferrero. Cura editoriale di Emma Bas.
Cura redazionale di Pia Cigala Fulgosi e Stefano Zicari.
Alexandre Dumas era considerato uno scrittore “classico” già prima che i nostri nonni fossero nati. Senza aver letto alcunché delle sue opere, alla fine del 1800, alcuni personaggi dei suoi romanzi erano riconosciuti dai letterati e dal pubblico, archetipi dei tipi e dei comportamenti umani. Si pensi ai “Tre moschettieri” e al “Conte di Montecristo”. Vi sono altri romanzi meno noti, ma incisivi nel delineare tratti universali del nostro animo.
Era uno scrittore dotato di una memoria eccezionale, di una capacità investigativa e di ricerca superlativa e di una creatività inesauribile. In più, oltre a saper descrivere in modo minuzioso il contesto attraverso i dialoghi dei personaggi, caratteristica che discrimina la grandezza di un romanziere, è un antropologo moderno. L’osservazione degli usi, dei costumi, dei tratti fisici delle persone e dei luoghi, è di un livello pari agli etnologi, agli antropologi culturali moderni.
Viaggiò molto, massone e repubblicano. Amico di Giuseppe Garibaldi, fedele ai principi della rivoluzione francese, affine alla visione di Mazzini per una “Giovine Europa”, cementata dalla fratellanza e dalla libertà dei popoli.
“La Sanfelice” parla dei popoli e delle genti dell’Italia del sud. Del Regno delle due Sicilie, e in particolare di Napoli. Alexander Dumas visse a Napoli dal 1860 al 1864 circa, esule dalla Francia, e poi ancora dalla stessa Napoli e dai napoletani. Duramente critico, eppure di loro innamorato. Agì da “ministro dei beni culturali”, adempiendo con scrupolo al suo ufficio.
“La Sanfelice” apparve a puntate sul quotidiano parigino «La Presse» fra il 15 dicembre 1863 e il 3 marzo 1865 – e, con uno scarto di qualche mese (10 maggio 1864 – 28 ottobre 1865), sull’«Indipendente», il giornale che proprio a Napoli Dumas aveva fondato e diretto. Pressoché contemporanea l’edizione in nove volumi di Michel Lévy, Parigi, 1864-1865.
Suo padre partecipò alle guerre napoleoniche in Italia, e qui fu imprigionato per 25 mesi. Recarsi a Napoli fu anche un’occasione di riflessione sulla rivoluzione francese, sulla degradazione dei principi repubblicani per opera di Napoleone, sulle monarchie repressive europee, e in particolare con i Borboni e con gli stessi napoletani, che nel periodo tra il 1798 e il 1799 uccisero e si uccisero tra di loro, in modo che noi diremmo oggi barocco, esagerato, arrivando ad atti cannibalici contro i propri avversari. Un popolo di vinti perenne, tenuto a bada e volutamente diviso dai potenti, timorosi dai suoi scoppi improvvisi di ira, pieni di voluttà di sangue. Vi sono descrizioni truci, quasi da film dell’orrore, purtroppo verosimili.
Di prima lettura sembra che Alexander Dumas abbia scritto “La Sanfelice” per pareggiare il conto nei riguardi di quel regno che già allora era disprezzato per la sua arretratezza dalle coorti europee e dai suoi regnanti. Nel libro vi è una descrizione dei potenti, carica di ironia a tratti. La grandezza di quest’opera emerge dalla capacità di squadernare in modo quasi fotografico l’ambiente e le trame e le piccolezze dei potenti e del popolo.
Sarebbe limitato però fermarsi alla prima impressione, perché vi è anche una esaltazione della generosità degli stessi napoletani e degli altri personaggi del sud d’Italia, anche nel combattere tra di loro. Alexander Dumas l’avverte ed è rispettoso di queste terre, ricche di passato, e in realtà complesse, impossibili da qualificare con sguardi affrettati dai propri pregiudizi.
Fa bene leggere quest’opera perché immedesimandosi nei protagonisti realmente esistiti e in quelli inventati, ma verosimili nelle loro gesta ed azioni, storicamente determinate giorno per giorno, si sentono nel proprio animo, i dolori, le speranze, le paure, lo strazio, l’amore provato. È un romanzo lungo, ma ricco di sentimenti ed emozioni.
Vi è l’onestà intellettuale di comunicare al lettore la veridicità dei fatti storici attraverso i documenti realmente esistenti, e alcuni eventi delle scene, dispiegati attraverso la fantasia dello scrittore. E fu questo il successo iniziale da parte del pubblico, perché si sentiva partecipe di questo appuntamento bisettimanale, e mensile, pari a una telenovela brasiliana per la lunghezza dei mesi, nonostante si sapesse già la fine e la sorte dei protagonisti.
“La Sanfelice” nasce da esigenze personali, politiche, di lavoro ed estetiche, ed è un libro pianificato, e scritto passo passo per 18 mesi, attraverso ricerche storiche correlate, testimonianze e controlli in loco dei luoghi descritti. È una creazione estetica mediante un lavoro da storico e da antropologo. L’autore interviene direttamente nel testo per serrare le fila e precisare al lettore ciò che è scaturito dalle ricerche e dalle sue valutazioni.
Allora ed oggi, il lettore si sente a suo agio e ha fiducia nell’autore, perché mostra senza giri di parole, i suoi intenti e li delimita, permettendo al pubblico, il godimento nell’approccio di lettura.
Alexander Dumas offre un quadro del nostro passato e di quello che ancora di esso abbiamo, da osservatore partecipante, addolorato, critico, ma in fondo innamorato dell’Italia e di Napoli.
“La Sanfelice” è un tesoro cui attingere le tecniche di scrittura dei dialoghi, e della ricchezza nel mostrare l’animo umano, le caratteristiche morali e fisiche delle persone, dei luoghi e le tracce di ricostituzione della nostra memoria inconscia, all’interno di processi storici ben determinati.
Ed è utile per esercitare le capacità di analisi quasi sociologiche. Un esempio tra tutti:
Pgg. 334-35
“[…] Ma a che è dovuta questa differenza fra gli individui e le masse? Perché a volte il soldato fugge al primo colpo di cannone e il bandito muore invece da eroe?
[…]
Ecco i princìpi essenziali:
Il coraggio collettivo è la virtù dei popoli liberi.
Il coraggio individuale è la virtù dei popoli che sono soltanto indipendenti. Quasi tutte le popolazioni di montagna – gli svizzeri, i corsi, gli scozzesi, i siciliani, i montenegrini, gli albanesi, i drusi, i circassi – possono benissimo
fare a meno della libertà, purché si lasci loro l’indipendenza.
Passiamo a spiegare che differenza enorme ci sia fra queste due parole: LIBERTA’
e INDIPENDENZA.
La libertà è la rinuncia da parte di ogni cittadino a una porzione della sua indipendenza per costituirne un fondo comune che si chiama legge.
L’indipendenza è per l’uomo il godimento completo di tutte le sue facoltà, l’appagamento dei suoi desideri. L’uomo libero è l’uomo che vive in società, che sa di poter contare sul suo vicino, il quale a sua volta fa affidamento su di lui. E, essendo disposto a sacrificarsi per gli altri, ha il diritto di esigere che gli altri
si sacrifichino per lui. L’uomo indipendente è l’uomo allo stato naturale. Si fida
soltanto di se stesso. I suoi unici alleati sono la montagna e la foresta. La sua difesa, il fucile e il pugnale. I suoi aiutanti sono la vista e l’udito.
Con gli uomini liberi si costituiscono degli eserciti.
Con gli uomini indipendenti si formano delle bande.
Agli uomini liberi si dice, come Bonaparte alle piramidi: «Serrate le file!».
Agli uomini indipendenti si dice, come Charette (85) a Machecoul: «Divertitevi, figlioli!».
L’uomo libero si leva alla voce del suo re o della sua patria.
L’uomo indipendente si leva alla voce del proprio interesse e della propria pass ione.
L’uomo libero combatte.
L’uomo indipendente uccide.
L’uomo libero dice: «Noi».
L’uomo indipendente dice: «Io».
L’uomo libero è Fraternità.
L’uomo indipendente non è altro che Egoismo.
Ora, nel 1798, i napoletani erano ancora nella fase dell’indipendenza. Non conoscevano né la libertà né la fraternità. Ecco perché furono sconfitti sul campo da to cinque volte meno numeroso del loro.
Ma i contadini delle province napoletane sono sempre stati indipendenti.
Ecco perché, alla voce dei monaci che parlavano in nome di Dio, alla voce del re he parlava in nome della famiglia, e soprattutto alla voce dell’odio che parlava
in nome della cupidigia, del saccheggio e della strage, si sollevarono tutti.
[…]”
–
Oggi noi potremmo criticare questa divisione così netta, ma quello che interessa osservare è che, in base agli eventi descritti precedentemente, Alexander Dumas fornisce la sua chiave interpretativa nel delineare gli eventi.
–
Il lettore è coinvolto in prima persona e sente di essere rispettato nella sua intelligenza e nella sua capacità di riflessione.
–
Alexander Dumas mentre parla del passato della sua famiglia, di sé e delle sue convinzioni, ha la mirabile capacità di costringerci in modo inconscio a guardare a noi stessi, alla nostra storia e a riflettere sul presente di oggi.