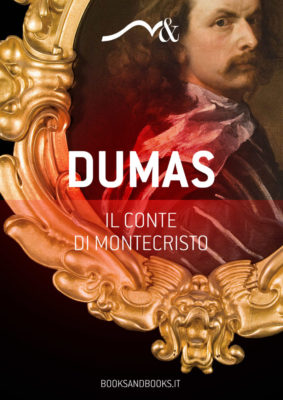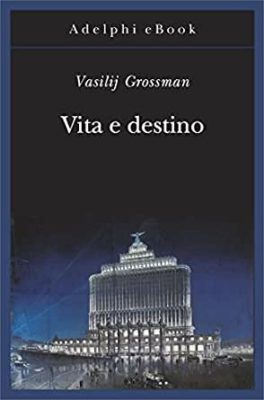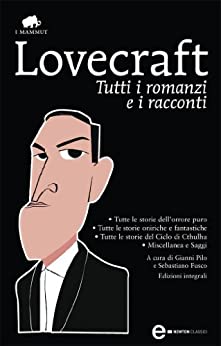
L’opera intera di Howard Phillips Lovercraft indica una riflessione rivolta alla condizione di limitatezza che è propria dell’essere umano nel comprendere il senso del mondo e nell’essere artefice del proprio destino. La copiosa quantità di racconti mostra l’ineluttabile sconfitta a contenere la verità ultima delle cose e delle cause, e la grama facoltà di poterlo raccontare. La realtà è indescrivibile: l’altro e il cosmo agiscono in piani imperscrutabili, talvolta per noi minacciosi e distruttivi.
–
Il male esiste e la sua incidenza dipende dalla nostra impossibilità a contenerlo, capirlo, dominarlo. Certamente possiamo resistere, ma la quota di questa difesa dipende dal grado di consapevolezza dell’esistenza di eventi ed identità che vivono in scale immensamente più grandi del nostro vivere.
–
Il male riveste la maschera dell’orrore nel momento in cui ognuno rifiuta di vederlo, e quindi di scrutarsi. Anche nella propria interiorità si annidano i demoni. La speranza di ottenere qualche istante di sopravvivenza in più, risiede nella disponibilità a nominarli in modo indicale, e non sostantivo, perché impossibilitati a comprenderli. Tanto più si riesce a sopportare il dolore e la paura, quanto meno sottraiamo secondi della nostra vita all’orrore che, comunque, arriverà sicuramente con la sorella nera.
–
L’essere umano vive in quella sponda cosmica oscura, in cui per una eternità non è esistito, e successivamente è accompagnato dall’unica certezza che in un battito di ciglia ritornerà in quella condizione.
–
La disperazione può essere lenita dalla possibilità di raccontarla. L’unico medicamento efficace per non impazzire consiglia di comunicare la condizione di stare affondando verso l’urlo della disperazione, gorgogliando echi che annunciano sprazzi del proprio annichilimento.
–
Gli scritti di H. P. Lovercraft investono una condizione universale che oscilla tra la tentazione di confondere la realtà con la propria descrizione, e quindi di sostituire il linguaggio al mondo, anche per il tentativo di stabilire una nozione razionale del “male”. È data per scontata la volontà a ordinare quello che chiamiamo caos, che è tale invece per la deficienza che è propria dell’essere umano. La comprensione di sé come scheggia di vita che ha come tratto distintivo il muto urlo interiore, ha l’unica speranza di illudersi a un vivere in cui si è resistenti alla paura e al dolore, nell’esprimere la propria interiorità che è aggrappata al ciglio dei demoni, oscillando nel burrone del tempo che rende friabile ogni appiglio.
–
L’illusione che l’altro capisca il silenzio paralizzante del proprio vivere e che a sua volta corrisponda con una sensatezza a noi coerente, è il senso del vivere che l’opera di H. P. Lovercraft offre nell’esalare i pochi attimi di presenza al mondo, evitando l’immediata e solitaria pazzia che distende la via più veloce verso la morte.
–
Il suo stile varia nei racconti, mantenendo però timbri costanti nell’uso immaginifico delle sinestesie e nella sovrabbondanza quasi pittorica degli aggettivi che accompagnano le azioni dei singoli e le intere vicende della storia narrata. La contingenza, come unico stato di senso, ha bisogno di uno stile quasi espressionista dal punto di vista pittorico, informando però che quello che è descritto non è la grandezza del mondo, ma l’infinita sconfitta a negare i propri limiti nell’attribuire un significato a ogni oggetto e stato del mondo.
–
È coinvolgente e superlativo a evocare ciò che in ogni ora di qualsiasi giorno cerchiamo di tenere nei bassifondi della nostra esistenza interiore, costituita dal male che tentiamo di negare e di proiettare al di fuori, e dalla volontà di vivere che si denota esclusivamente per la sua disperata debolezza e nel timore per tutto ciò che la circonda.
–
Questa lettura poderosa è un’occasione che facilita il perseguimento di una facoltà di giudizio più matura nel tentare di chiarire le nostre risorse intellettive. E, inoltre, custodisce una miniera di risorse linguistiche a immaginare mondi provvisoriamente coerenti che siano da noi giudicati più accettabili per evitare il panico e la follia.
–
[CREDITI: Alcune di queste riflessioni hanno preso spunto dalle monografiche di Riccardo Dal Ferro (canale Youtube “ RickDufer”). ]