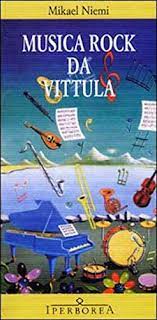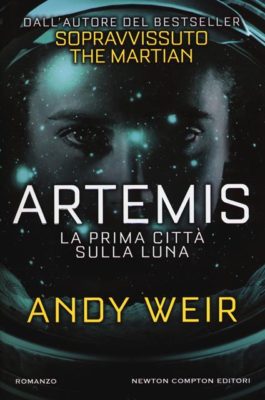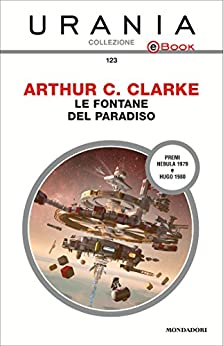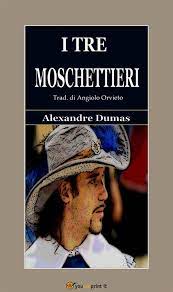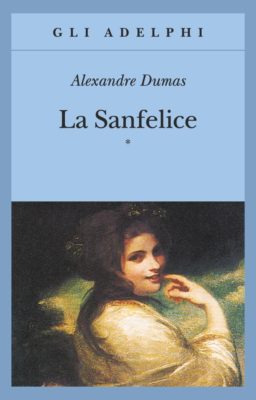prima ed. 1964, Rizzoli, Milano
Tanti lati nascosti ha quest’opera. Racconta i luoghi e gli eventi, immersi in un processo storico in cui l’incanto della natura antropizzata unisce l’antico e il mito. L’autore è anche il protagonista che incarna il mito di Ulisse, ma verso se stesso. Il suo “io” è Itaca. Tutto converge nel suo monologo.
–
I fantasmi, coloro che sono rimasero adolescenti a metà, li riporta in vita affinché il loro destino sia compiuto in un appuntamento della memoria. Ognun di loro inizia il viaggio per ricongiungersi nella voce di Luigi Meneghello.
–
L’autore rinnova quelle gesta, scrivendo da adulto, le parole e gli atti della gioventù. Si fa da parte, in modo che i morti riassumano un articolo determinativo. La cornice ha lo scheletro della resistenza dei partigiani tra l’armistizio del giorno 8 settembre 1943 e la fine della seconda guerra mondiale e la cornice dei racconti dei comunisti, dei cattolici, dei libertari, secondo gli inni degli anni cinquanta, degli anni sessanta, e negli anni di “piombo”.
–
Vi è l’intento di ricollocare la biografia e la cronaca in un quadro depurato dalle retoriche derivate dalla guerra fredda. Ed ecco, quindi, che il mito assume una posa lirica, in cui il protagonista, parla con le montagne e con le valli del Veneto, nella speranza di colloquiare con gli dei, con la natura e con il tempo dei cicli e dei riti. Tutti coloro che furono maestri a metà, perché morti, o fermati dal loro percorso originario di scopi e di speranze, verso di lui si approssimano e si abbeverano alla fonte del suo scritto.
–
La versione di quest’opera è degli anni settanta, dieci anni dopo la prima pubblicazione. E inizia nel momento in cui lui, ventiduenne, assieme ad altri amici universitari, lascia tutto e va nelle montagne per assumere il ruolo di partigiano.
–
È una formazione in itinere. Ognuno di loro aveva una razionalità limitata riguardo alla guerra, alle tecniche di resistenza, e alle modalità di organizzare azioni contro i tedeschi e contro i fascisti della Repubblica Sociale. Lo stile all’inizio è quasi simile, all’inizio, a un resoconto di cronaca. È preciso nei dettagli dei luoghi, nella descrizione puntuale dei paesaggi e dei personaggi, fino alla singola piega o strappo di un vestito. Eppure, ed è qui l’effetto caleidoscopico, è anche un romanzo di formazione, perché narra una crescita che parte da una istanza morale: darsi una dignità per sé e per le proprie comunità, dopo il disonore fascista, la vergogna della disfatta, la guerra civile, e l’abbraccio fraterno al sanguinario tedesco.
–
È delineato un approccio antitetico alle mitopoiesi partigiane e a quelle dei fascisti “buoni” che si scontrarono, si ritrovarono in quel periodo, tra i lutti, le vendette, gli orrori, e le lacerazioni presenti fino ad oggi. I libri e la retorica diaristica e politica negli anni cinquanta e sessanta ponevano sì uno scontro duro, e di rivendicazione, ma ammettendo, nonostante tutto, il valore di chi resisteva e anche di quei pochi, pochissimi che mantennero l’umanità stando dalla parte “sbagliata”, siano stati essi compagni confusi o fascisti.
–
Luigi Meneghello narra le sue vicende e di quelle dei partigiani di area comunista, liberale, cattolica, o semplicemente di comunità e locale, in una progressiva acquisizione di strategie e tecniche di guerra, di maggiore consapevolezza ideologica, e di un maggiore affinamento delle proprie valutazioni morali, MA non attraverso il mito dell’eroe partigiano, del grande guerriero, della gioventù gloriosa.
–
Gli eventi topici sono contraddistinti da dubbi, errori ed atteggiamenti goffi quasi comici, all’interno degli epiloghi tragici in cui i suoi compagni morivano così, quasi per sbaglio o incuria.
–
Tutte quelle persone furono piene di dubbi, di limiti, di pregiudizi, analfabete quasi, neanche tanto intelligenti, piagate dalle malattie, e con disabilità varie. Eppure resistettero nel rifugiarsi nelle montagne, negli attentati, nel sopportare la fame e il freddo, nel morire malamente e nell’attuare una lotta clandestina in pianura, dentro le città. Nel litigare tra comunisti, socialisti, comunisti antisovietici, liberali, repubblicani, realisti, cattolici proto ecumenici, e quelli ortodossi, e contro la grande maggioranza amorfa, suddivisa nelle preoccupazioni quotidiane e in un fascismo di convenienza, pronta ad aderire al potente di turno.
–
La narrazione assume toni comici, nonostante il racconto si snodi tra tragedie e toni lirici e commoventi, nel recepire il senso ancestrale delle comunità in rapporto al paesaggio natio. E qui vi è un nostro errore prospettico di lettori. Luigi Meneghello non voleva risultare comico mentre scriveva, perché siamo noi oggi, ad avvertire lo scarto delle retoriche del valore, degli eroi, e di come queste siano piccole, semplici, tronfie rispetto all’oceano degli eventi che accaddero. Un popolo debole, corrotto dalle proprie bugie, che si trova ad affrontare una realtà che consapevolmente contribuì ad evocare.
–
Eppure, nonostante le avventure maldestre e picaresche, Luigi Meneghello è indulgente verso il giovane che fu e verso tutti gli altri, gran parte uccisi e rimasti giovani lì, per sempre. È un padre che si avvicina e li abbraccia, perché, nonostante tutto, in modo irriflesso, inconscio, rozzo ebbero una caratura etica, tesa all’estremo sacrificio per di mantenere una postura dignitosa nella tensione verso la libertà con le mani aperte, callose, ma pulite.