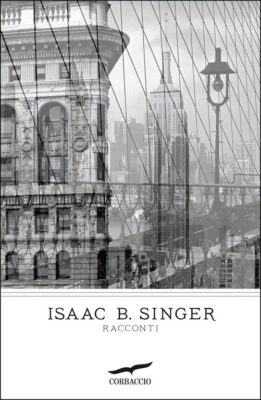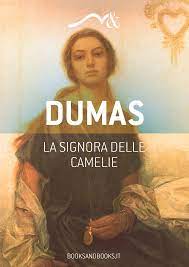G. Pozzo (Traduttore), 2010 (prima edizione 1891),
Iperborea, Milano
La saga è avvincente e parla dei luoghi atavici della Svezia anche in relazione con le comunità finniche. Vi sono come nelle saghe a noi vicine, i luoghi universali dell’eroe che lotta contra il nemico, l’estraneo, il bosco, le entità sovra mondane e quelle degli abissi. Il pericolo e le minacce provengono anche dal cuore degli esseri umani, sì virtuosi, ma passibili di cadere nel male.
–
Il bisogno di crescere, di procreare, e di accedere nell’aldilà, è continuamente ostacolato dall’imprevedibilità del mondo. Il racconto, come in ogni saga, e quindi in ogni narrazione che tesse i miti, tenta di porre un ordine e di chiudere i cicli, per continuare a a dotare di senso lo scorrere del tempo.
–
Dagli ordini ciclici della natura, si passa a quello degli stadi della nascita, alla giovinezza, fino alla morte, in modo che l’ostacolo e l’attrito che si ha contro gli altri, il mondo, il mistero, si accordino come i criteri morali e leggi del mondo, che sono anche etiche, aventi a fondamento quelle ultra mondane.
–
Poiché nelle storie che riproducono il senso del mondo, alcunché può esser lasciato fuori, ogni oggetto e manifestazione naturale hanno un senso che oltrepassa la semplice presenza; il solo stare. Vi è sempre una intenzione talvolta non immediatamente manifesta, una caratteristica della materia, l’influsso di uno spirito, il moto dell’intero mondo. Lo scopo è quello di avere un “se e un allora”, che fornisca al tempo, una comune ragione del “cosa è”, del “chi è”, e del “perché dell’agire e del divenire”. I luoghi sono quelli dell’eroismo, dell’amore, dell’avidità, del coraggio, della cedevolezza, della prole, e della morte.
–
La saga di Selma Lagerlöf è tutto questo e di più. Ebbe un successo che diede all’autrice la possibilità di continuare a scrivere e a divenire una delle prime scrittrici quotate ed autonome nella attività imprenditoriale tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento in Svezia.
–
L’opera è qualcosa di più di una saga, perché, essendo un’opera che fu scritta in tempi lunghi e con racconti autonomi, anche nella pubblicazione preliminare nelle riviste, si snoda cambiando le prospettive, in base agli affinamenti dello scrivere dell’autrice. Da una serie di racconti a tema, si passa ai tempi di un romanzo. Da precetti già dati nel piano della morale, e dalla meccanica dei conflitti del protagonista contro il mondo, l’animo, la virtù, i precetti morali, la seduzione, il vizio, diventano la trama che descrive una comunità negli accadimenti della storia ciclica.
–
Se nelle saghe tradizionali ed arcaiche che hanno un sapore orale, prima ancora della loro trascrizione, i protagonisti sono netti, chiari, aventi qualità e debolezze che fanno già intuire i loro appuntamenti nefasti o gioiosi con il destino, qui i cavalieri, i nobili, i fabbri, i sacerdoti, il male stesso, da reali e concreti, diventano di volta in volta, i luoghi mitici del racconto post datato, o figure implete, o emanazioni delle divinità paniche, fino a quelle religiose per ritornare poi ad essere in carne ed ossa. Stesso percorso è subito dai boschi, dai fiumi, dai mulini, dai guadi dei fiumi, agli animali e agli spiriti dei boschi che assumono un percorso speculare.
–
Vi sono in verità più racconti paralleli che si manifestano nei diversi episodi, incrociandosi talvolta.
–
Si passa dai toni picareschi, a quelli di formazione adolescenziali, a quelli di amor sacro e profano, fino alle storie edificanti. Non mancano riferimenti embrionali dell’orrore a quelli lirici.
–
L’autrice è abile, spregiudicata, curiosa nell’attraversare i generi entro la struttura della saga. La forza, la distorce, cerca di creare un nuovo stile, anzi più di uno. Invece di definirli compiutamente, però, li lascia incompiuti e li fa cozzare uno con l’altro. Lasciando l’idea che non è detta l’ultima parola sugli eventi narrati.
–
È una saga che esce fuori dalle regole canoniche. È un romanzo dell’ottocento che trasforma i protagonisti con più personalità in una forma novecentesca, perché usano la razionalità e le parti nascoste di sé per porsi in relazione con gli spiriti dei boschi e le allegorie monoteistiche.
–
In alcuni episodi l’epica volge in un’avventura sulle navi, sulle coste e sui fiumi, ma anche lì rimane inceppata, per ritornare sui luoghi saldi della terra.
–
È comunque coinvolgente: i dialoghi non sono banali, e, nonostante le dichiarazioni di virtù e di sacrificio, le norme e gli usi e le consuetudini vengono continuamente poste a critica.
–
È un arcipelago di stili che si tengono insieme e stimolano la fantasia del lettore, solleticando l’indole a vedere con occhi nuovi e più profondi, i meccanismi con quali attribuiamo senso alle cose.
–
Quest’opera è un tesoro pieno di monete di diverso conio, che sta a noi, raccogliere e inquadrare in base ai nostri bisogni di progettare il futuro, e i vincoli morali.